|
I cittadini e l’accesso alle
informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente
Il diritto di accesso alle informazioni e
la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è
ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello
nazionale che internazionale.
Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della
comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli
che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella
protezione dell’ambiente.
La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si
concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono
tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini.
Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le
questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di
tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello
nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso
alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità
pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale.
Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale
conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia
la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla
giustizia.
1.
Principali
normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al
processo decisionale
2. Il diritto di
informazione in materia di ambiente
3.
Il diritto di
partecipazione al processo decisionale
4.
La Convenzione
di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico in materia di ambiente
2. Il diritto di
informazione in materia di ambiente
Il diritto all’informazione in materia
ambientale costituisce una delle principali tematiche di politica
ambientale affrontate dall’Unione europea.
Tali tematiche pur in assenza di una esplicita previsione nella
versione originaria del Trattato, sono state oggetto di importanti
iniziative a livello comunitario fin dai primi anni ’70. Ma è
soprattutto la metà degli anni ’80, proprio in corrispondenza con
l’elaborazione di quei principi che hanno portato alla modifica del
Trattato con l’art. 130R (Atto Unico Europeo) il periodo nel quale la
problematica relativa al diritto all’informazione in campo ambientale
viene ad acquisire sempre maggior rilievo. Questa coincidenza non è
casuale. Infatti il diritto all’informazione ambientale può essere
inquadrato nell’ambito del principio di “azione preventiva”, il quale
costituisce (insieme a quello della “correzione anzitutto alla fonte
dei danni causati all’ambiente” e al “chi inquina paga”) uno dei tre
cardini fondamentali della politica comunitaria in materia ambientale
contenuti proprio nell’art. 130R del Trattato.
Il decennio 1980 – 1990 è quindi il
periodo fondamentale per l’elaborazione e lo sviluppo del diritto
all’informazione ambientale nell’ambito delle politiche di tutela
ambientale della Comunità.
Più in particolare, poi, l’origine del dibattito nato intorno
all’opportunità o meno di creare una direttiva specifica
sull’informazione in materia ambientale, si fa risalire anche al più
generale obiettivo di provvedere al raggiungimento di una maggiore
trasparenza nelle attività dell’Unione Europea e, d’altro canto,
nell’ottenimento di una maggiore partecipazione dei privati alle
procedure decisionali.
Il maturato interesse per la protezione dell’ambiente in ambito
comunitario, il riconoscimento del diritto dei cittadini ad un
ambiente salubre ed il crescente potere delle associazioni
ambientaliste hanno portato ad una focalizzazione del problema,
limitando l’oggetto della direttiva alla materia ambientale in quanto
tale, più che all’attività amministrativa in generale.
Lo scopo da raggiungere era quello di creare un atto che fosse in
armonia con le legislazioni nazionali degli stati membri e che, allo
stesso tempo, garantisse una volta per tutte la trasparenza
dell’attività dell’Unione Europea sull’ambiente e la partecipazione
attiva dei cittadini europei ai procedimenti decisionali. É stato
questo un passo avanti nel lungo cammino verso il riconoscimento di un
diritto assoluto ad un ambiente salubre, progetto ambizioso, ma
necessario.
L’idea di creare una Direttiva europea che disciplinasse la materia in
oggetto è diventata col tempo sempre più una realtà. Il ‘diritto
all’informazione in materia ambientale’ soddisfa, quindi, la necessità
non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche dei privati, di essere
informati su atti e documenti prodotti non soltanto dalle
amministrazioni pubbliche, ma anche dalle aziende e concessionarie
che, nell’ambito della loro attività, sono tenute a rispettare le
norme di protezione
dell’ambiente.
La soddisfazione di tali necessità vedeva, comunque, un ostacolo nella
legislazione nazionale di molti Stati membri, preoccupati di non poter
attendere agli obblighi che il progetto iniziale prevedeva. Così,
soltanto dopo cinque anni dalla prima proposta, la direttiva è stata
approvata e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
In base all’art. 9 della direttiva, gli Stati erano tenuti a recepirla
nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 1992, ma soltanto la
metà ha provveduto in tempo. L’Italia l’ha recepita il 24 febbraio
1997 con il decreto legislativo n. 39.
Tra gli elementi caratterizzanti la Direttiva vale la pena di
sottolineare la generalità di tale diritto, ovvero la capacità di
chiunque (interessato o meno) a richiedere informazioni sullo stato
dell’ambiente, intendendo con esso tutto ciò che riguarda lo stato
dell’aria, dell’acqua, del suolo, della fauna, della flora, del
territorio, nonché informazioni sulle attività nocive o misure che
possono incidere negativamente sull’ambiente, compresi gli atti
amministrativi di gestione dell’ambiente.
Nella direttiva sono anche stati disposti casi tassativi per i quali
le amministrazioni possono rifiutarsi dal cedere le informazioni, al
di fuori di tali eccezioni non esiste alcuna possibilità di rifiuto o
rigetto delle richieste.
Le informazioni possono, inoltre, essere richieste non soltanto a
qualunque organismo pubblico (come ad es. tutte le istituzioni
comunitarie, l’Agenzia europea per l’Ambiente, e gli altri enti che
detengono per l’Unione europea le informazioni), ma anche agli enti,
pubblici e non, concessionari di pubblici servizi.
A circa dieci anni dalla Direttiva 313/90, però molte voci si
sono levate per chiedere di ampliare il diritto di accesso
all’informazione in materia ambientale e consentire che allo stesso
potesse corrispondere anche un rafforzamento dei diritti dei cittadini
europei alla partecipazione al processo decisionale e all’accesso alla
giustizia.
Così a seguito dell’approvazione della Convenzione di Aarhus,
ispirata ad un particolare favor per l’accessibilità delle
informazioni ambientali, è cominciata la revisione della Direttiva n.
90/313/CEE conclusasi di recente con l’emanazione della nuova
Direttiva 2003/4/CEE (G.U.C.E. del 14.2.2003 n. 41).
In realtà si è precisato che “è opportuno, nell’interesse di una
maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché
modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo
unico, chiaro e coerente” (direttiva 2003/4/CE – considerando 6).
Questa direttiva fornisce una definizione di informazione ambientale
più ampia e completa della precedente e per alcuni aspetti anche della
Convenzione di Aarhus, stabilisce anche i contenuti ritenuti minimi
della documentazione amministrativa disponibile per il pubblico in
generale.
Si legge, infatti, “la definizione di informazione ambientale dovrebbe
essere chiarita per comprendere l’informazione, in qualsiasi forma,
concernente lo stato dell’ambiente, i fattori, le misure o le attività
che incidono o possono incidere sull’ambiente ovvero sono destinati a
proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche
usate nell’ambito di tali misure e attività, nonché l’informazione
sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in
cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi
elementi.”
La direttiva è infatti impostata per lasciare una maggiore libertà di
accesso agli atti e far sì che vi siano pochi e specifici casi in cui
tali informazioni possano essere negate.
Vero è che la Direttiva 2003/4/CE dovrà essere recepita dagli Stati
membri entro il 14 febbraio 2005 e che pertanto le disposizioni dianzi
richiamate non sono allo stato precettive; tuttavia i principi
innovativi enunciati dalla Direttive ed il favor per l’ampliamento
dell’accesso ad essa sotteso dovrebbero costituire parametri
imprescindibili anche ai fini della interpretazione e della
applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 39/1997.

per maggiori informazioni sulle Direttive
Europee e le leggi italiane che disciplinano l’accesso del pubblico
all’ informazione ambientale |
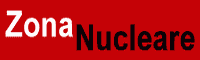 Il sito unico
nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ,
Il sito unico
nazionale per la raccolta delle scorie nucleari , 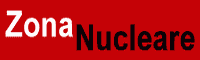 Il sito unico
nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ,
Il sito unico
nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ,